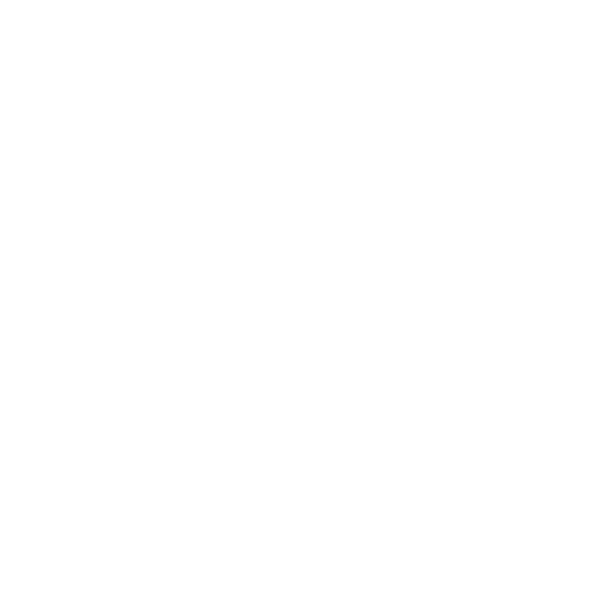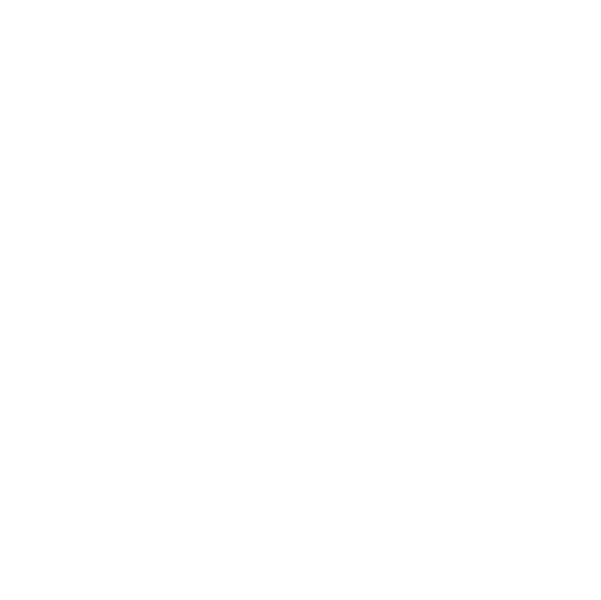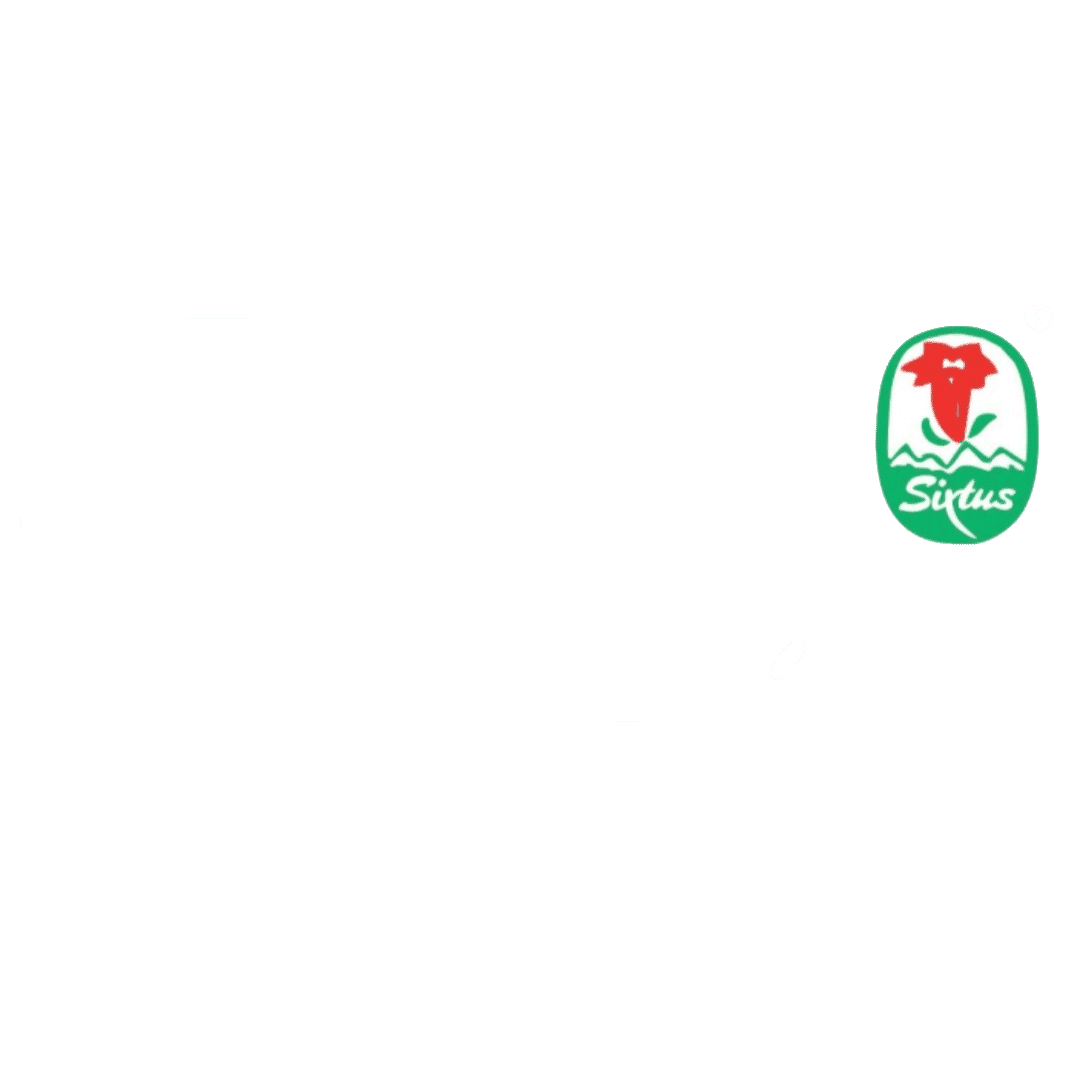Il test Conconi, ideato dal Professor Conconi, è diventato famoso perché attraverso la valutazione della frequenza cardiaca, in una particolare zona, è possibile visualizzare la soglia anaerobica dell’atleta.
In questa occasione parleremo di questo test di soglia. Entreremo nella descrizione dell’esecuzione e analizzando i risultati che possiamo ottenere.
Indice dei contenuti
Test Conconi: cos’è la soglia anaerobica?

Come abbiamo visto in precedenza l’articolo su acido lattico e l’articolo su allenamento anaerobico il concetto di soglia anaerobica è molto importante.
Infatti, si riferisce al momento in cui nel nostro organismo si viene a verificare un brusco incremento dei livelli di lattato nel sangue. Questo corrisponde alla soglia dei 4 mmol/l.
Affidabilità del test Conconi
I test fisici vengono utilizzati nell’ambito sportivo per avere un quadro completo delle qualità fisiche dell’atleta.
Quando si prende in considerazione un test da somministrare, si deve tenere conto di alcune caratteristiche tra cui, l’affidabilità. Questa si divide in affidabilità assoluta che rappresenta il grado con cui le misurazioni ripetute variano tra gli individui, e l’affidabilità relativa. Quest’ultima corrisponde al grado in cui gli individui mantengono la loro posizione in un campione con misurazioni ripetute.
Un test deve avere anche caratteristiche di ripetibilità e riproducibilità. Soprattutto però, deve avere una validità, ovvero il grado con cui il test misura ciò che propone di misurare.
Cos’è il test Conconi
Il test di Conconi è un test di tipo incrementale e massimale. Esso ci permette di indagare la frequenza cardiaca (FC) e la velocità di soglia (KM/H), tramite la relazione tra frequenza cardiaca e la velocità.
Il test può essere svolto sia in campo che su treadmill.
Ogni atleta prima di iniziare il test deve indossare un cardiofrequenzimetro che ci permette di monitorare la frequenza cardiaca.
Come strutturare il test Conconi
Si inizia all’andatura di 8 km/h con incrementi di velocita pari a 0,5 km/h ogni 200 metri.
Se il test viene effettuato in campo o preferibilmente in una pista di atletica, il percorso è delimitato da coni posti ad una distanza di 50 metri. Tramite un segnale acustico emesso ad intervalli, permette all’atleta di modificare la propria velocità in corrispondenza dei coni posizionati lungo il tracciato.
Il test viene interrotto quando l’atleta non riesce più a proseguire o non riesce ad arrivare puntuale in corrispondenza del cono.
Ad ogni incremento di velocità viene registrata la frequenza cardiaca a cui successivamente verrà messa in relazione.
Analizzare i dati del test Conconi
Il test di Conconi ci da la possibilità di ricavare come già detto la frequenza cardiaca e la velocità che vengono messe in relazione in un grafico. In questo troviamo sull’ascissa la velocità mentre sull’ordinata la frequenza cardiaca.
La relazione progredisce con un andamento lineare. Infatti la frequenza cardiaca cresce in maniera proporzionale all’aumentare della velocità, finché non si nota una deflessione, dove i due parametri monitorati non cresce in modo proporzionale, ma in maniera più ridotta.
Il punto di deflessione rappresenta il momento in cui nel nostro organismo si verifica un accumulo crescente di lattato nel sangue. La stesura del grafico indica qual’è la soglia anaerobica (punto di deflessione) del nostro atleta in termini di velocità e frequenza cardiaca.
Validazione del test Conconi
Il test di Conconi ha dato la possibilità di ottenere un test da campo non invasivo per il calcolo del massimo lattato allo stato stazionario (mlss). Questo test è supportato un gran numero di indagini sulla sua validità.
Come possiamo vedere dagli studi di “Kuipres at al. 1988; Tokmakidis and Leger 1992 ne hanno messo in dubbio la sua affidabilità e validità, che sono state però validate dagli studi di Hofmann et al. 1994; Bunc et al. 1995.
Perchè eseguire il test Conconi?
Questo è un test di facile esecuzione, incrementale e massimale. Inoltre ci permette anche di trovare la frequenza cardiaca massima dell’atleta.
La situazione più complessa forse risulta nel definire in maniera chiara riconoscendo il punto di deflessione della curva.
Sicuramente avere una stima indiretta della sua soglia anaerobica è importante, ma sarebbe molto più opportuno poterla valutare direttamente con un metabolimetro e un prelievo di lattato.
Lorenzo Sabatini
Vuoi imparare a programmare l’allenamento utilizzando anche il test Conconi?
Scopri come il Team PerformanceLab utilizza il test Mognoni, e non solo, nella preparazione pre-campionato. Questo è il periodo tra i più importanti nella stagione dove iniziare a valutare gli atleti sia a livello metabolico, sia a livello neuromuscolare.
Il Corso è sempre disponibile online al seguente link: bit.ly/preparazioneprecampionato